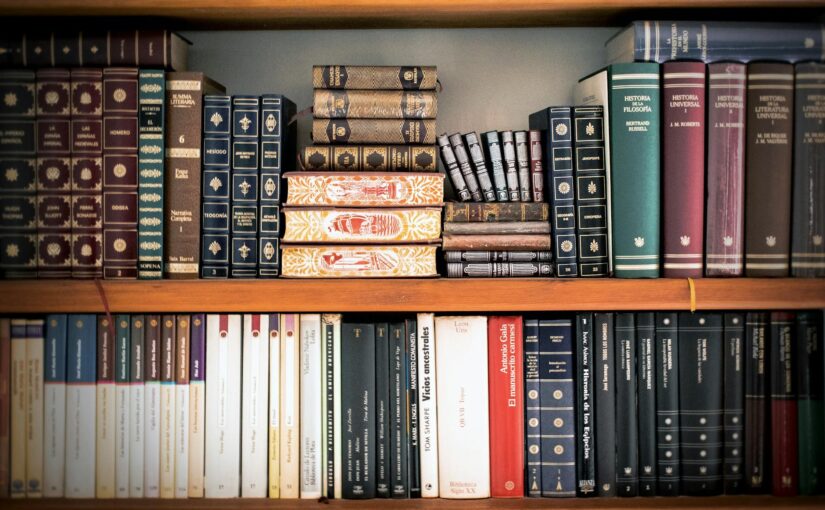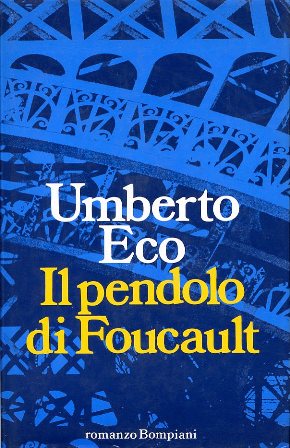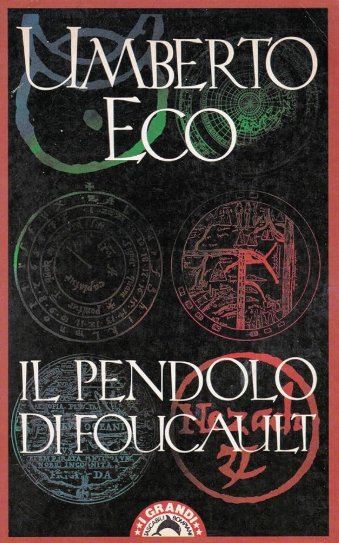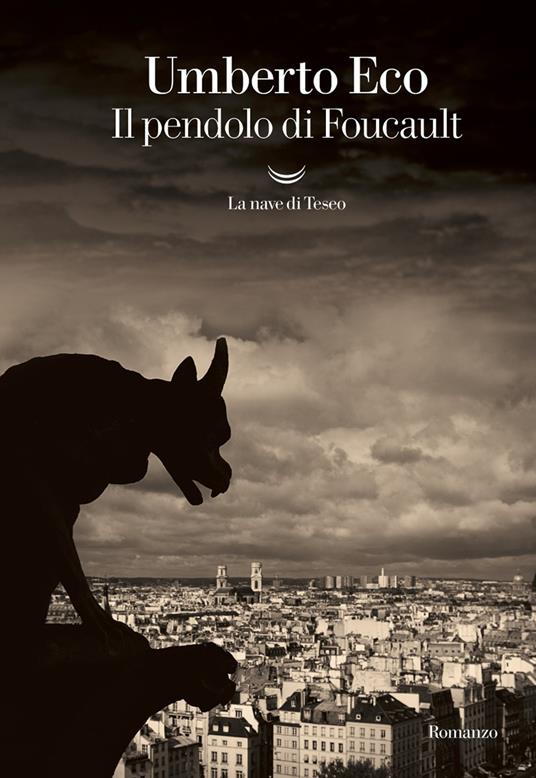Per quanto il tema possa sembrare banale, per non dire addirittura contaminato da una retorica di fondo, credo che una sua trattazione sistematica e approfondita possa riservare molte più sorprese del previsto.
Ossia, è piuttosto evidente quanto pochi siano quelli che si svegliano la mattina anteponendo un auspicio del genere ai pensieri su inflazione, strade dissestate, costo della benzina e dei libri scolastici, bollette e via discorrendo. Ma credo nonostante tutto che un’idea di “diritto” al creare, nell’accezione che andremo a precisare di seguito, sia centrale e opportuna per una serie di ragioni molto eloquenti.
Definizioni di creatività
Se per creatività intendiamo banalmente il lavoro di artisti, musicisti, pittori, scenografi, scrittori e affini, allora il confinamento alla sfera professionale svilisce certamente la mia argomentazione, in quanto è evidente quanto tali campi possano costituire direttamente l’oggetto di un lavoro retribuito, disciplinato da contratti e affini. D’altra parte, se qualcuno scrive poesie o dipinge paesaggi per il proprio piacere personale, è altrettanto evidente quanto questo stesso piacere costituisca certamente un valore difendibile, ma non certo un diritto inalienabile e di fondamentale importanza.
Se invece parliamo della creatività come facoltà generale di pensare in modo alternativo, di risolvere problemi complessi, di ampliare l’orizzonte, di vedere meglio la realtà e di individuare vie inedite per lo sviluppo di idee, allora la questione diventa più vasta, e arriva a toccare ambiti sociali, filosofici, psicologici e civili che giustificano il mio assunto iniziale.
Esiste quindi una questione aperta sul diritto alla creatività, inteso evidentemente come diritto potenziale che in questo nostro mondo apparentemente così aperto e multicolore viene di fatto negato con efficacia censoria che ha dell’incredibile. Questione aperta, ma sotterranea e invisibile.
L’idea di spaziotempo
Per quel che mi riguarda, io penso che l’aspetto fondamentale per giudicare l’assenza del diritto alla creatività sia profondamente legato non già al comune tema del “tempo negato” all’individuo, per effetto di coercizioni dirette e indirette derivanti dal mercato del lavoro e dalle moderne schiavitù imposte da forme di iper-competizione ormai riprodotte ovunque, ma allo “spaziotempo negato”, cioè a un insieme di tempo, luogo e qualità degli stessi per esercitare prassi che in mancanza vengono a risultare alla stregua di diritti negati, sia pure indirettamente.
Lo spaziotempo necessario alla creatività altro non è che un tempo sufficientemente omogeneo e uniforme che si svolge in un luogo “idoneo”, ossia dotato delle caratteristiche minime per svolgere un lavoro creativo. Dico “minime” perché non è assolutamente detto che una scrivania d’oro zecchino sia migliore di una normale tavola di legno posta su due cavalletti, né che la scrittura su carta avoriata con stilografica di lusso possa garantire una qualità creativa più elevata di quella garantita da una risma di buona carta da fotocopie e una penna a sfera.
Per “qualità” e “idoneità” dello spaziotempo mi riferisco invece a una dinamica molto più sottile, che cercherò di descrivere con un esempio concreto.
Supponiamo che io sia un manager che si trova nella suite di un grande albergo a cinque stelle, con a disposizione praticamente tutto quello che serve per rilassarsi, leggere, scrivere, guardare una serie TV o un film. Supponiamo anche che io stia attendendo una telefonata molto importante, sulla base della quale potrò capire se avrò modo di continuare il mio lavoro di sempre, oppure se sarò licenziato in tronco. Supponiamo anche che questa telefonata debba arrivarmi durante la giornata. Passa un’ora, e non arriva. Passano due ore, tre ore, e ancora si fa attendere. Arriva il pomeriggio, e niente, il telefono non squilla. Così fino a sera, minuto dopo minuto.
A questo punto qualcuno potrebbe molto superficialmente dire: “Caspita, di cosa ti lamenti. Non hai fatto nulla tutto il giorno. Avresti potuto leggere, scrivere, guardarti un film, e invece hai passato tutto questo tempo a girarti i pollici.”
Ebbene, ha senso questa affermazione? Dal punto di vista strettamente (e stupidamente) “formale” ha purtroppo senso, in quanto sì, è vero, io per tutto il tempo non ho fatto “formalmente” nulla, pur avendo la possibilità “formale” di fare quello che dice il qualcuno di cui sopra.
Ma sul piano “sostanziale” io ho fatto eccome qualcosa: ho passato un intero giorno ad attendere ansiosamente una telefonata che non arrivava mai. Avrei potuto leggere, scrivere, guardare la TV? Sì, ma con che clima interiore? Possiamo pensare che questa attesa che “formalmente” individua un lungo tempo passato senza fare nulla sia anche “sostanzialmente” idonea alla creatività?
Questo esempio spiega chiaramente cosa io intenda per “qualità dello spaziotempo” come alveo naturale per lo svolgimento di un lavoro creativo.
Spiace dirlo, ma gli impegni, le responsabilità, i figli, i genitori anziani, i problemi di lavoro, le mille preoccupazioni della vita frenetica sono oggettivamente un fattore di abbassamento della qualità dello spaziotempo, ovvero della sua idoneità al lavoro creativo.
Come spero ovvio, e a scanso di equivoci, non sto dicendo che la vita possa essere priva di questi fattori, né che si possa ragionevolmente immaginare di avere a disposizione quindici o sedici ore giornaliere per esercitare non professionalmente la propria creatività. A questo mondo tutti noi siamo chiamati a lavorare, a sacrificarci, a opporre resistenza a una serie di innumerevoli ostacoli e asperità, ed è evidente che nessuno di noi può pretendere di farne a meno senza incorrere in scelte il cui radicalismo può veramente non valere la candela.
Tuttavia il nostro mondo sta andando un tantino oltre questa ragionevolezza. La frenesia, le incomprensioni, le aporie e le contraddizioni rese aspre dai conflitti e dalle fazioni che ogni giorno si fronteggiano nella Grande Rete così come nella famiglia, nelle comunità e nei luoghi di lavoro, e non da ultimo una crisi economica e sociale “di sistema” nella quale sembra veramente che tutti debbano essere contro tutti, sono tutti fattori che ci stanno sottraendo ogni forma di qualità e di idoneità da dedicare ad azioni che sono tutt’altro che puro ozio.
La creatività: il come e il perché
Semplificando all’ennesimo grado, io credo che le attività creative che permettono di generare valore entro “congrue e idonee porzioni di spaziotempo” siano sostanzialmente due:
- La fase creativo-percettiva, con fruizione opportunamente tranquilla e indisturbata di libri, film, opere musicali, ma anche corsi, seminari, tutorial e qualsiasi altro stimolo passivo che possa generare potenziali ispirazioni.
- La fase creativo-fattiva, ossia la generazione attiva di idee, scritti, opere, soluzioni, implementazioni aventi appunto a che fare con la traduzione della componente divergente del punto uno in output innovativo, utile, pregevole e in grado di migliorare la nostra vita e quella altrui.
Intendiamoci, per implementare queste due fasi serve ovviamente del tempo, ovvero dello spaziotempo di qualità che possa dirsi al riparo dalle continue richieste di mogli e mariti, figli e figlie, genitori, colleghi, seccatori e via discorrendo. Ma non stiamo parlando di chissà che soggiorni vacanzieri nell’isola che non c’è.
Un lavoro creativo di altissima qualità può svolgersi tranquillamente lungo tre o quattro ore a settimana. Basta solo che in queste ore non ci sia nulla che possa disturbarci a parte il gatto che vuole le sue crocchette.