





C’è poco da fare: a me piacciono i blog classici, che evocano l’atmosfera dei libri e delle biblioteche che li contengono. (Mi rendo conto di quanto l’aggettivo “classico” sia comunque ambiguo. A rigore un blog “classico nel mondo dei blog” dovrebbe ricordare la grafica del Web 1.0, con le sue squadrature semplicistiche e i suoi colori fastidiosi. Ma questa è un’altra storia…) Ecco perché ho cambiato ancora una volta impostazione grafica. Mi perdonerete, ma è più forte di me. Sono tante cose, e trovare la forma per tutte le stagioni del mio essere è complesso. Forse impossibile.
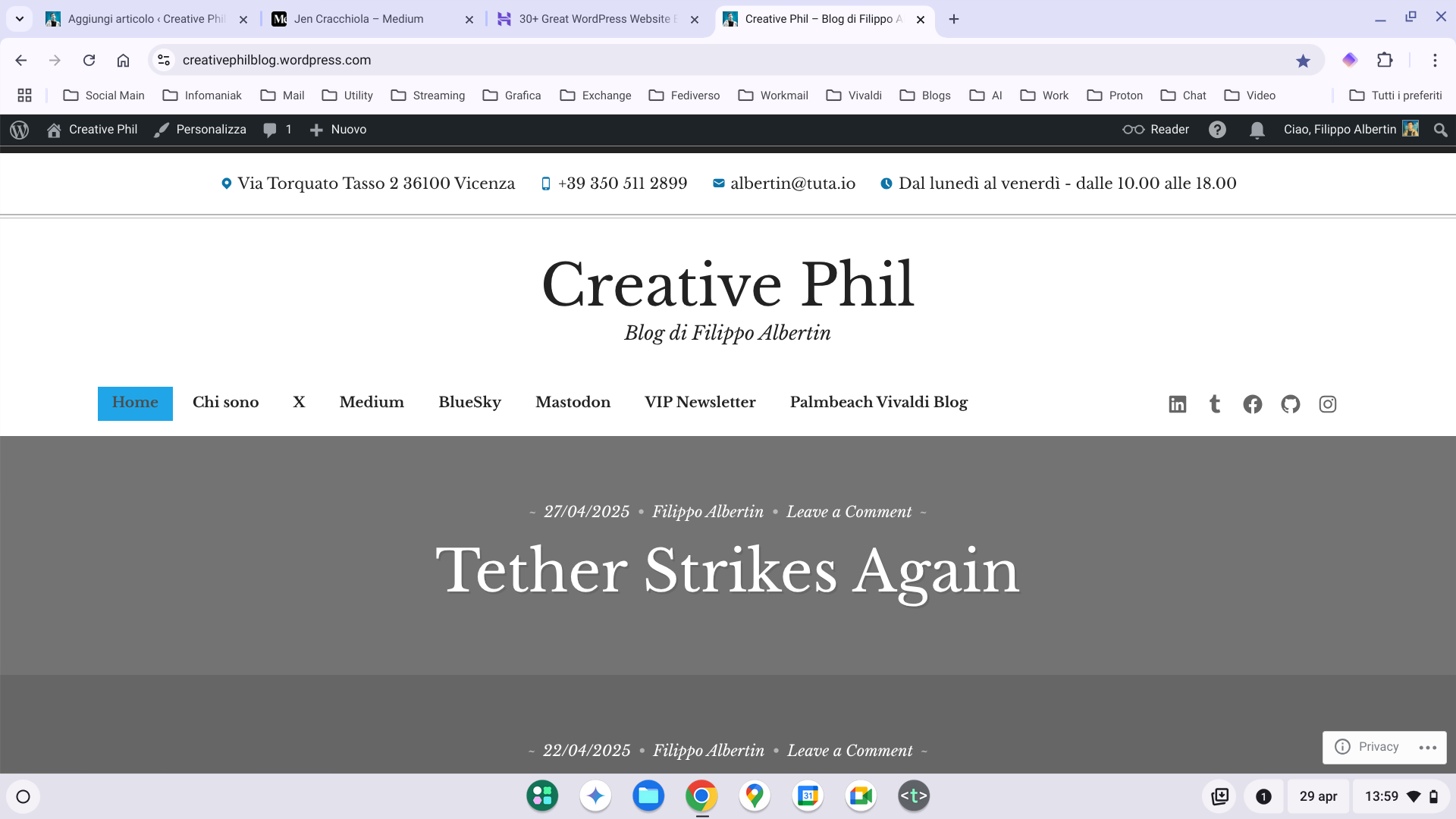
In definitiva, questa versione leggermente modificata di Radcliffe mi piace parecchio.
Rimarrà questa? Non lo so, e in generale non credo. Però ne terrò conto per questo o per altri blog che avrò in mente di mettere in rete.
Oggi, relativamente alla mia rinnovata pubblicazione in Substack, esce di fatto il primo contenuto dedicato ai soli abbonati. Si tratta della prima puntata di una serie di articoli dedicati a quello che ho chiamato “sillabario minimo” del management creativo inteso come insieme di procedure, tecniche puntuali e atteggiamenti generali da tenere dentro il processo di generazione e implementazione delle idee.
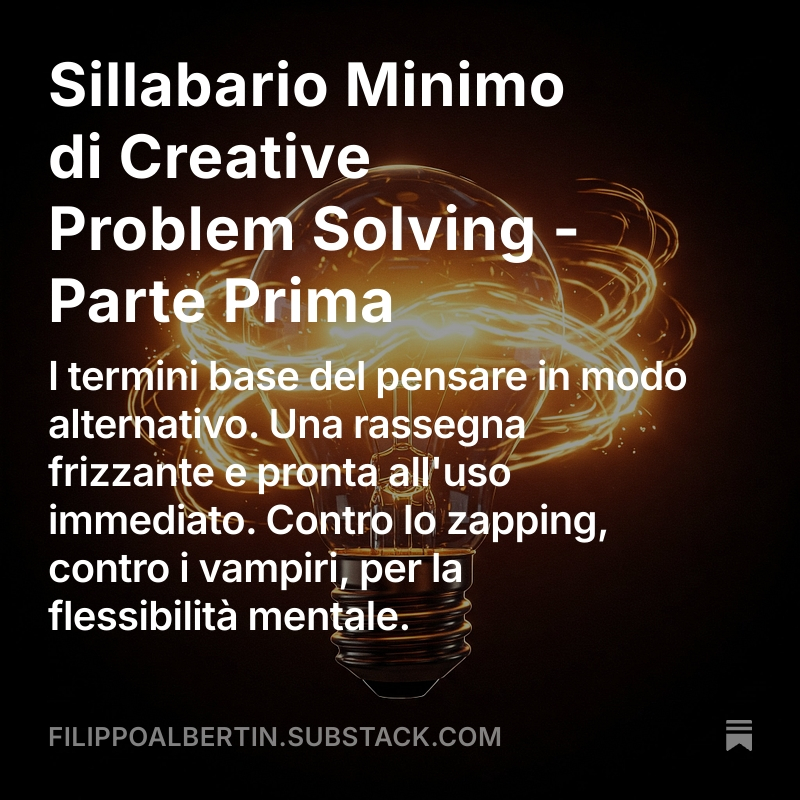
Il potenziale piano dell’opera andrà poi a prevedere ragionamenti più legati al frameworking, concetto fondamentale che racchiude l’idea di un metodo in grado di procedere in via sinottica, contemplando però specifiche macro-aree “attorno” al sopraccitato processo, molto utili per padroneggiare l’intero meccanismo.
Sempre all’interno della pubblicazione sarà possibile vedere miei “lavori” in termini di visual thinking, sketchnote in primis.
Non parlerò solo di management, ma anche di innovazione, tecnologia, blockchain e applicazioni nel campo aziendale e finanziario, con ampia comunicazione e condivisione di contatti chiave e dritte. Ecco perché la pubblicazione è stata impostata come bollettino privato, ossia dedicato a un pubblico definito.
Per gli amanti dell’innovazione, della tecnologia, delle tecniche e strategie di management mediate da procedimenti alternativi (lateral e visual thinking, business aware design, etc…), nonché per chi tratta tematiche attinenti a campi quali Bitcoin, blockchain, criptovalute, finanza decentralizzata e intelligenza artificiale, ho leggermente modificato il mio account Substack trasformandolo in una testata a pagamento (cinque euro al mese, oppure quaranta all’anno, cifra minima se consideriamo quanti libri e quanta esperienza possa celarsi nella favella di uno come me, e vi faccio notare la modestia).
Scherzi a parte, confezionerò ancora contenuti per i non abbonati — dalle news agli inviti aperti al vasto pubblico — ma il grosso sarà rappresentato da informazioni VIP, riservate solo a una stretta cerchia di appartenenti al club. Le ragioni sono varie, ma la prima è molto semplice: il mio tempo è quasi interamente dedicato alla scrittura di articoli e al networking connesso al mio lavoro, quindi, se proprio devo scrivere di tematiche a vario titolo professionali, vorrei farlo solo per i quasi clienti o per lettori veramente interessati a supportare la mia scrittura.
L’abbonamento di cui sopra, oltre ai contenuti speciali, include una chat in presa diretta ed esclusiva con me e la mia community. Quindi, come dire, potete pormi domande estremamente intime. Professionalmente intime, intendo.
News News NEWS | via Non Euclidean Manager Zone (Substack)
Arrivato ora a sancire le mie passioni grafiche online…

Fanno sempre piacere queste gratuità. In ogni caso, sì, con Canva ho fatto veramente un sacco di cose. Design per le masse, si direbbe. Ancora una volta ho saccheggiato un celebre album della memoria storica musicale.
La parola di oggi è superdraft. Il neologismo allude all’idea di una bozza perpetua, o meglio di un laboratorio di testi occulti che vengono elaborati in tempi protratti, per poi essere pubblicati tutti in una volta. Una sorta di contrario della letteratura d’appendice, in questo caso applicata al blogging.
Quanto alla post-it mania suscitata da Nick Eagleton, credo che sia una delle cose che maggiormente dovrò sviluppare. La questione è concreta: un desktop puramente elettronico non basta, sta stretto, è scomodo. D’altra parte, non mi piace l’idea di un muro di casa adibito a bacheca. Non rientra nei miei canoni estetici.
Se ci pensiamo, un post può essere una sequenza di ritagli. Io, per esempio, scrivo e disegno molte cose che in forma del tutto frammentaria deposito nel mio Mastodon. Una sketchnote, per esempio…
Poco fa mi è capitato di scrivere questa cosa sui classici, che da tempo mi solleticava e che alla fine ho messo in forma scritta. Anche in questo caso, un’annotazione su Mastodon…
Trovo che il remix migliore sia però quello che riporta annotazioni fatte di testo e immagini…
Oggi sono incappato in un sito veramente molto ben realizzato, appassionato e soprattutto utile. A me la dicitura “disegno brutto” però non piace molto, perché in realtà i risultati di questa metodica non porgono assolutamente un output effettivamente brutto. Più che altro direi selvaggio, spontaneo, immediato, bambinesco, con uno stile che ricorda peraltro svariati grandi artisti della grafica e della pittura (Saul Steinberg, Paul Klee, solo per citarne alcuni).

Se poi ci spostiamo al campo del pensiero visuale, l’adagio di Mike Rohde parla chiaro: riferendosi alla tecnica della sketchnote (da lui ideata), la denota precisando che riguarda le idee, e non l’arte. Quindi, nel parlare di immagini che servono a pensare, ci riferiamo comunque a una forma di disegno che si valuta per la sua funzione, e non per il suo contenuto estetico.
Ma è veramente così? Secondo me no, ovvero non proprio, e la realtà è ancora più sottile e intrigante. Cercherò di spiegarla al meglio.
Esiste a mio avviso un’estetica della funzionalità, una sorta di punto intermedio, di proporzione quasi aurea, che dovrebbe intercettare un affinarsi lungo la via del disegnare non manieristico, ma comunque legato a un’efficacia comunicativa che è nel contempo funzione e bellezza. Esiste, cioè, un galateo che non allude alla bellezza, che so, di un’immagine copiata a mano con precisione fotografica, o di uno schizzo in perfetta prospettiva annotato da un abilissimo architetto, ma risponde a esigenze diverse, a sensibilità alternative, nonché a istanze altrettanto conformi alla bellezza in senso lato.
Il rifiuto del manierismo non è il rifiuto di una certa concezione dell’equilibrio compositivo, che può tranquillamente essere fatto di eccessi e di misure, in un mix che la pratica può efficacemente individuare.
Il mio modo di disegnare è solo mio. Procede per tentativi, giustapposizioni, montaggi, che hanno come unico scopo la costruzione di qualcosa che serva. Tutto qui.


Oggi ho dedicato ben tre NFT all’artista statunitense La Monte Young. Non so perché. Sta di fatto che mi piace pensare a queste tre mie opere che viaggiano lungo la rete decentralizzata, collezionate da decine e decine di individui.
La prima rappresenta una sorta di pittura astratta. La seconda ha un carattere altrettanto astratto, ma più elettronico, schematico, da intelligenza artificiale o metodo matematico. La terza ha un carattere più “spazialista”, per certi versi il più affine al compositore. Tutte fanno riferimento al concetto di “dream house”, un luogo dove affinare i sensi per la fruizione di opere quali appunto quelle del nostro.
A vario titolo e per varie ragioni, in questo periodo mi sto interessando di creazione di contenuti; ovvero, della (fantomatica) figura del content creator.
Per quanto la perifrasi sia effettivamente l’ennesima — diciamocelo chiaramente — mistificazione che usa l’inglese come lasciapassare di un’originalità del tutto presunta, che nasconde certamente cose antiche e banali (dal coworking che è e rimane un banale “affitto di scrivanie” ai vari talk che altro non denotano se non “discorsi in pubblico” che si tengono dall’epoca di Cicerone esattamente nello stesso modo), il mondo attorno alla creazione di contenuti è certamente interessante.
La ragione di questo interesse è sicuramente il rapporto tra mondo fisico e mondo digitale, con uno sguardo molto attento alle tecnologie che oggi permettono di liberarsi più o meno totalmente di ogni figura intermedia tra creatore e fruitore. Parlo essenzialmente della blockchain, ossia di quel costrutto informatico che ha permesso la nascita e l’ascesa delle cryptovalute, e oggi sta alla base della rivoluzione degli NFT, token non fungibili che mimano alla perfezione il comportamento di un’opera d’arte unica e irripetibile che passa di mano in mano — di wallet in wallet — attraverso procedimenti crittografici automatizzati.
Senza tanto perdere tempo nel parlare degli altri creatori di contenuti, parlerò di me. Perché sì, io mi ritengo un creatore di contenuti, nonché un docente — versato in tecniche creative e di visual thinking (ok, questa volta ho usato io un termine inglese, ma solo per necessità di sintesi) — che ha spesso insegnato ad altri ad esserlo. Quindi, vorrei fare il punto su me stesso.
A me capita di fare tante cose. Sono un crypto entusiasta che lavora come consulente freelance Bitcoin e Altcoin, ma adoro i film degli anni Trenta. Disegno in bianco e nero su carta, eppure adoro l’arte digitale e i suoi luminosi cromatismi a schermo. Colleziono e uso penne stilografiche di ogni tipo, ma quasi sempre scrivo a schermo. Amo il synthpop anni Ottanta che veniva veicolato da musicassette fisiche (peraltro tornate di moda), però non potrei fare a meno degli mp3. E via discorrendo.
Non ho mai amato le accozzaglie, né mai le amerò; ma di certo il rapporto tra digitale e analogico mi ha insegnato un dettaglio illuminante. Il vero e grande punto di forza del “mezzo” informatico e telematico è la capacità di veicolare con assoluta efficacia ed efficienza un mix di elementi multimediali eterogenei in una forma univoca e coerente.
L’idea deriva dalla mia lettura di Steal Like ad Artist, di Austin Kleon. Il creativo colleziona cose diverse, apparentemente conflittuali e non miscibili. La sommatoria di tutte queste, però, restituisce l’identità del creativo stesso. Quindi non bisogna tanto preoccuparsi di come verranno assemblati certi materiali. L’importante è collezionare tutto ciò che sembra significativo, scartando il resto.
Quando osservo qualcosa che mi piace, subito dopo averla collezionata (leggi, rubata) inizio subito a chiedermi con quale altra poterla remixare al fine di comunicare quel qualcosa che non posso fare a meno di comunicare.
L’arte, per me, è un remix. Non necessariamente un remix di oggetti posti sullo stesso livello. Può essere anche un remix inedito di stili applicati a un determinato soggetto, o di posizioni filosofiche, o di colori, forme, approcci, cornici, schemi.
Ma attenzione. Il mio metodo — o manifesto — non indica nel remix una sorta di “a prescindere” estetico. Al contrario, io mescolo solo se posso in qualche modo intuire un senso, una particolare efficacia.
Ultimamente, per esempio, sono affascinato da come un normalissimo post di blog — cioè un articolo — possa diventare vera e propria opera d’arte collezionabile attraverso la tecnologia dei non fungible token. Se ci pensiamo, un articolo è esattamente un remix: di immagini, testo, video, musica… Quale forma migliore per veicolare l’idea di arte che ho appena descritto?
Nella mia pagina Cent, propongo spesso opere collezionabili (quasi sempre gratis, a volte a pagamento) in forma, appunto, di articoletti con un titolo, alcune frasi e una o più immagini.

A volte remixo immagini puramente digitali. Altre volte riciclo miei disegni attraverso tecniche di rielaborazione cromatica, riproducendo effetti che altrove mi sono piaciuti.





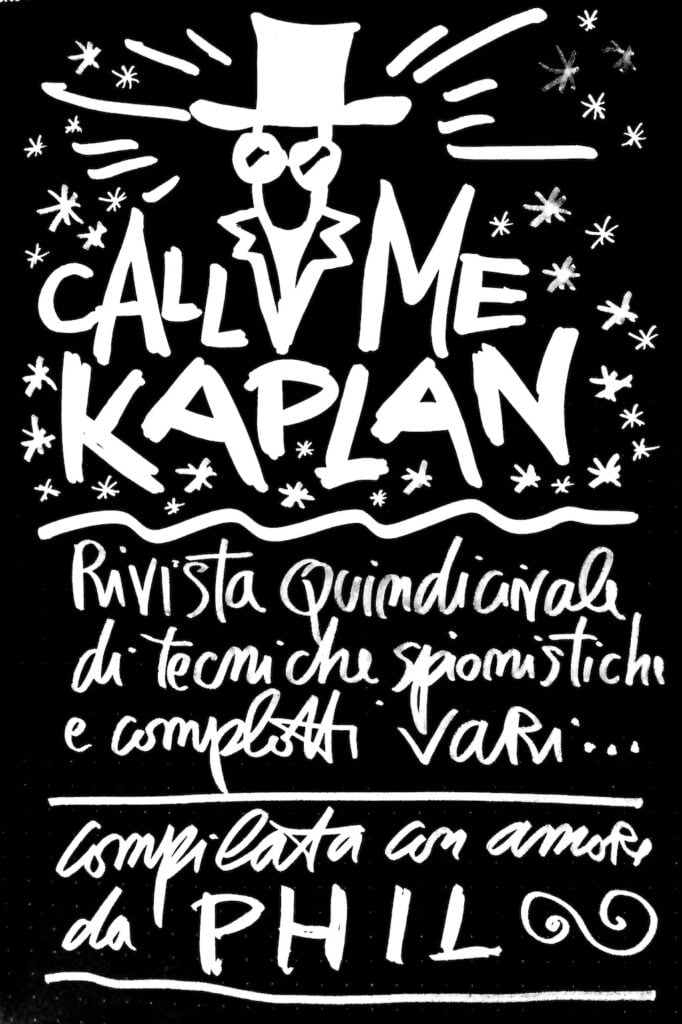
Dal punto di vista strettamente estetico, direi che il risultato finale, nella sua varietà “riconducibile a me”, mi soddisfa. Nonostante questa soddisfazione, però, io ritengo che il ruolo di un content creator oggi come oggi non possa prescindere da qualcosa di più. Questo qualcosa in più a mio avviso somiglia molto — mi si passi la perifrasi piuttosto pindarica — all’idea di smart contract che sta alla base del funzionamento di determinate transazioni in blockchain. Ossia: ciò che noi oggi possiamo chiamare arte, o più in generale design, sia esso fatto con carta e penna, sia esso elaborato con le più articolate tecniche elettroniche di rendering tridimensionale, non può viaggiare senza un contenuto ulteriore. Questo contenuto secondo me è l’appartenenza a una community, a un pensiero comune, a una condivisione di strumenti e filosofie… Tutte cose che un NFT può veicolare in modo automatico tramite il suo meccanismo di funzionamento.
Un NFT collezionato è frutto di una transazione. Può essere una transazione in denaro (digitale), oppure un regalo fatto a fronte di un’azione. In ogni caso, lo specifico NFT posseduto dal singolo è di volta in volta biglietto, tessera annuale, amuleto, lasciapassare, chiave di sblocco funzioni all’interno di un sito, prova di fedeltà, status symbol, oggetto da apporre come avatar, e mille altre cose.
L’arte digitale deve diventare strumento di comunicazione operativa, spicciola, terra terra. Abbiamo bisogno di comunità dove l’estetica possa sfumare nella tokenizzazione del tutto.
Abbiamo bisogno di diffondere una cultura di creatività capillare, a disposizione di chiunque.
Il content creator, dunque, deve diventare protagonista in un contesto completamente opposto a quello, presunto e presuntuoso, del mero testimonial, che al contrario non produce nulla di originale, ma si adegua alla dittatura dello sponsor di turno, o dell’agente, o di qualsiasi altro elemento di mediazione non alla pari.
Un vero e proprio manifesto, dunque, il mio. Che propongo a voi esattamente così, senza alcun filtro o mistificazione.